Teléc (Taurus, Toro o Telets), il film che Aleksándr Sokúrov ha dedicato a Lénin nel 2001, è il secondo film della tetralogia sul potere che il regista (col frequente collaboratore Jurij Arábov) ha iniziato con Molóch (1999, su Hitler), e ha proseguito con Sólnce (Il sole, 2005, su Hirohito) e Fáust (2011).
L’impianto di Teléc è all’apparenza molto simile a quello di Molóch: in entrambi vediamo i leader politici protagonisti in un ambiente lontano dalla realtà, in ville principesche nebbiose e brumose circondate da boschi (Berghof e Górki Léninskie), alle prese con spie, militari e servizi segreti che limitano il loro agire. Il Lénin di Teléc, però, a differenza di Hitler, è un uomo malato e semi-paralizzato.
Sokúrov non specifica apertamente l’arco cronologico di ambientazione del film: la presenza di Pëtr Pákaln e le condizioni di salute di Lénin rappresentate (già insensibile nella parte destra del corpo) fanno pensare al 1922-’23, o in un periodo tra i due ictus (tra maggio e luglio ‘22) o direttamente dopo il secondo (dopo il dicembre ‘22).
Dopo la malinconica colonna sonora di Andréj Sígle (che musicherà i restanti film della tetralogia; Molóch non aveva una musica originale), ispirata alla variazione 12 della Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmáninov (scelta anacronistica: la rapsodia è stata eseguita un decennio dopo i fatti narrati nel film, forse alludendo alla scomparsa di Lénin come prodromo degli eventi occorsi negli anni ‘30), e che risuonerà come unico tema durante tutto il film, vediamo la facciata di Górki Léninskie (la dáča che il nobile Sávva Marósov aveva reso neoclassica nel 1909, e che Lénin espropriò dopo il 1918, a soli 10 km da Mosca) immersa nella nebbia mattutina prima che una serie di shots consecutivi ci mostrino il personale di servizio già al lavoro all’alba e il malconcio Lénin che si sveglia. E subito inizia il primo dei monologhi di Lénin, un po’ pubblici e un po’ mentali, che affollano Teléc dall’inizio alla fine.
–

–
Se Molóch alternava i nonsense di Hitler a diversi dialoghi di Goebbels, Borman o Eva Braun, in Teléc i personaggi secondari (la moglie di Lénin Nadéžda Krúpskaja, la sorella Maríja Ul’jánova, il capo militare della guardia del corpo Pëtr Pákaln, Stálin) sono meri contorni di una lunga riflessione filosofica di Lénin, incentrata soprattutto sulla ricchezza, sul potere e sulla violenza: la sua è però la riflessione di un malato neurologico, ed è quindi claudicante, inconcludente di nozionismi (non fa che ripetere sofismi sull’antipatia personale di Paul Lafargue nei confronti di Ludwig Feuerbach, storpiando i nomi dei filosofi), affetta da manie di onnipotenza (Lénin è sconcertato e deluso quando Krúpskaja gli conferma che dopo la sua morte tutto il mondo resterà come è sempre stato senza alcun cambiamento), disarticolata e smemorata, che conclude quasi tutti i pensieri perorando la violenza come unica soluzione delle contese, siano esse speculative o pratiche, e nella violenza scade spesso anche nel pratico e non solo nel filosofico (arriva a dire che se avesse avuto figli li avrebbe picchiati per renderli umili, e dà in escandescenze e tratta malissimo tutti quanti, in maniere che solo parzialmente si possono attribuire alla malattia).
Il primo pensiero che sentiamo di Lénin è sul temporale notturno appena finito, i cui rumori, nel sonno, sono stati da lui percepiti come una musica: per tutto il film, Lénin ricorderà questo temporale e si stupirà di vedere l’erba asciutta: evidentemente quel temporale era un sogno o un’allucinazione.
Un altro arrovellamento intellettuale è originato da un mellifluo medico, forse tedesco (sineddoche dei si vocifera 26 luminari, anche stranieri, che il Politburo assunse per curare il leader tra 1921 e 1922), che, parlando con Lénin durante una visita che sembra ortopedica ma che è probabilmente psichiatrica, gli fa credere che tutti i suoi mali spariranno quando riuscirà a moltiplicare 17 per 22. La moltiplicazione sarà per Lénin un tarlo per tutto il film, poiché le sue capacità neurologiche non gli permettono più di fare neanche le operazioni più semplici.
E mentre Lénin parla, blaterando e vaniloquiando, il film accompagna la sua logorrea con un sistema visivo molto complesso.
–
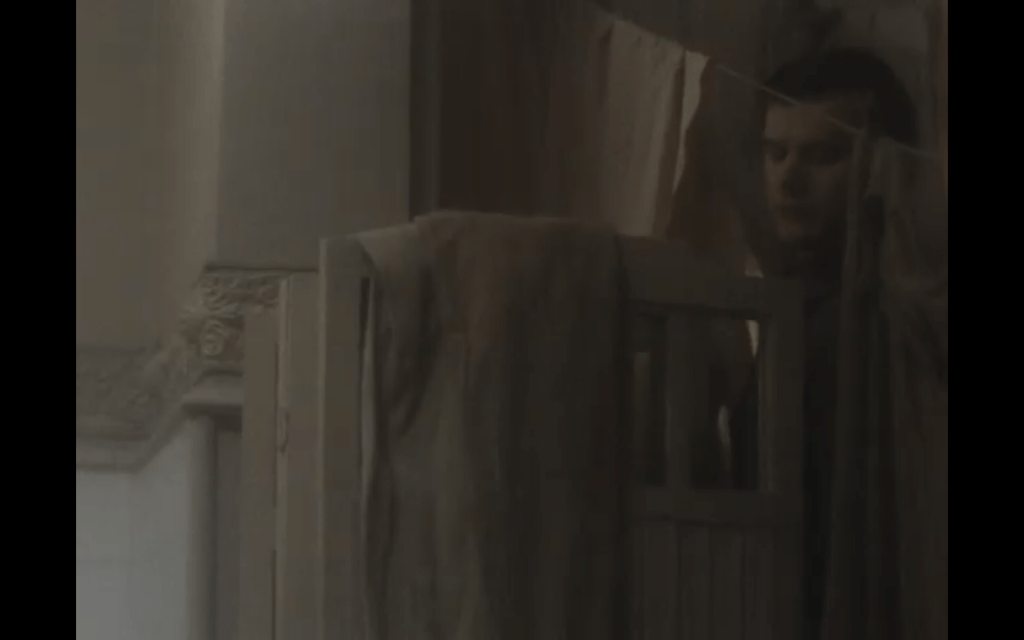
–
Se in Molóch le inquadrature apertamente e platealmente si deformavano, allineandosi ai pensieri “storti” di Hitler, la macchina di presa di Teléc è invece cristallinamente fluida e spesso immobile, oppure impegnata in lentissimissimi movimenti di macchina, quasi impercettibili (simili all’ultimo piano sequenza di Professione: reporter di Antonioni, 1975; o alla macchina estatica bradipesca dello Stalker di Tarkóvskij, 1979), che girano intorno apparentemente solo osservando, come dall’esterno, il Lénin parlante. Tali movimenti di macchina, però, non sono per niente innocenti né davvero solamente osservanti, poiché sono trapuntati da un sacco di inserti di gente che effettivamente spia Lénin (agenti dei servizi segreti, militari, domestici), e poiché sono movimenti che decidono di iniziare e finire non quando è significante per l’azione a fini mostrativi ma proprio il contrario: sono movimenti che iniziano e finiscono apposta per non farci vedere tutto un fuori campo che quei movimenti ci precludono. Uno dei primi che vediamo è quando la cameriera Šura si ferma a parlare con Lénin di quanto nessuno, tra gli abitanti della dáča, gli voglia bene: per molto tempo Šura e Lénin sono quasi pittoricamente composti (la fotografia dello stesso Sokúrov ha calligrafie cromatiche e compositive quasi botticelliane) in un’inquadratura fissa e molto ravvicinata su di loro, escludente tutto quello che sta intorno a loro, e che senza alcun motivo comincia a muoversi, abbracciando i due in modo circolare scoprendo così tutta la stanza rimasta fino ad allora fuori campo, ma appena ci ha fatto intravedere la stanza, il movimento si interrompe addirittura con uno stacco che inizia tutta una nuova sequenza! Sembra una parodia del famoso long take circolare del colloquio tra Johannes e la piccola nipote sul far morire e poi risorgere la madre della bambina (la cognata di Johannes) nell’Ordet di Dreyer (1955): lì Dreyer circondava quello che era il momento più significativo della sua trama appunto per sottolinearlo, esprimercelo e mostrarcelo; in Teléc, invece, Sokúrov usa uno stesso movimento di macchina circolare per non dirci nulla, ma solo per suggerirci che qualcosa c’è e che volutamente, o accidentalmente, non lo si vede.
Teléc è tutto composto di scene come questa: la macchina sembra fluida e innocente, lì a mostrare quel che accade, mentre invece mostra che ci sarebbe tanto in più da vedere ma quell’in più non lo si afferra, è precluso dalla visione proprio da quella stessa macchina da presa che potrebbe inquadrarcelo ma decide di non farlo, oppure non può farlo (sistema di ripresa con evidenti influssi antonioniani, non solo Professione: reporter ma anche tutta la produzione anni ‘60).
Questo modo di visione è forse la stessa mente di Lénin: malata e inceppata, avverte che ci sono cose intorno a lui ma queste gli sfuggono, gli vengono precluse, come la soluzione della moltiplicazione 17 per 22. E il movimento placido e fluido ma inconsistente delle immagini riflette i sillogismi di Lénin, superficialmente consequenziali ma invece del tutto campati in aria.
È come se Teléc fosse una gigantesca soggettiva del Lénin malato. Infatti, a questo proposito, è evidente un’altra differenza con Molóch: che i servizi segreti spiino Hitler è evidente da ostentate soggettive degli spianti, con la macchina da presa che coincide con i loro binocoli o con i mirini dei loro fucili; invece in Teléc si vedono tanti spianti, affacciati alle porte e alle finestre, ma non si vede mai quello che loro vedono: si vedono solamente gli spianti ma non quello che spiano. Come se le spie le vedesse Lénin (e una la vede perfino Stalin).
–

–
Nella trama ben poco “positiva” di Teléc, ci sono tre momenti più attivi: una gita in macchina nel parco di Górki Léninskie, la visita di Stalin e il pranzo susseguente.
Durante la gita, Lénin è convinto di essere a caccia e spara con il braccio buono, il sinistro, o credendo o facendo finta di credere che sia un fucile «donato dal popolo»: i militari della guardia del corpo Pákaln ridacchiano alla dicitura del «dono del popolo», già dimostrando come, nella popolazione, il motto marxista del «ciascuno lavora secondo le sue capacità e riceve secondo i suoi bisogni» fosse, all’alba della Rivoluzione, già diventato «ciascuno lavora quanto meno possibile e riceve quanto più riesce ad arraffare», con i «doni del popolo» già considerati vere e proprie refurtive. Con Krúpskaja leggono biografie di Marx, concentrandosi sul momento della morte del padre del Comunismo in riflesso all’imminente morte di Lénin che, purtroppo, non fermerà il mondo (accenno, forse, alla Rivoluzione comunista: un’esplosione immensa che però verrà riassorbita dal divenire del quotidiano come tutti gli eventi: un’ombra della tematica della Animal farm di Orwell, 1945).
–
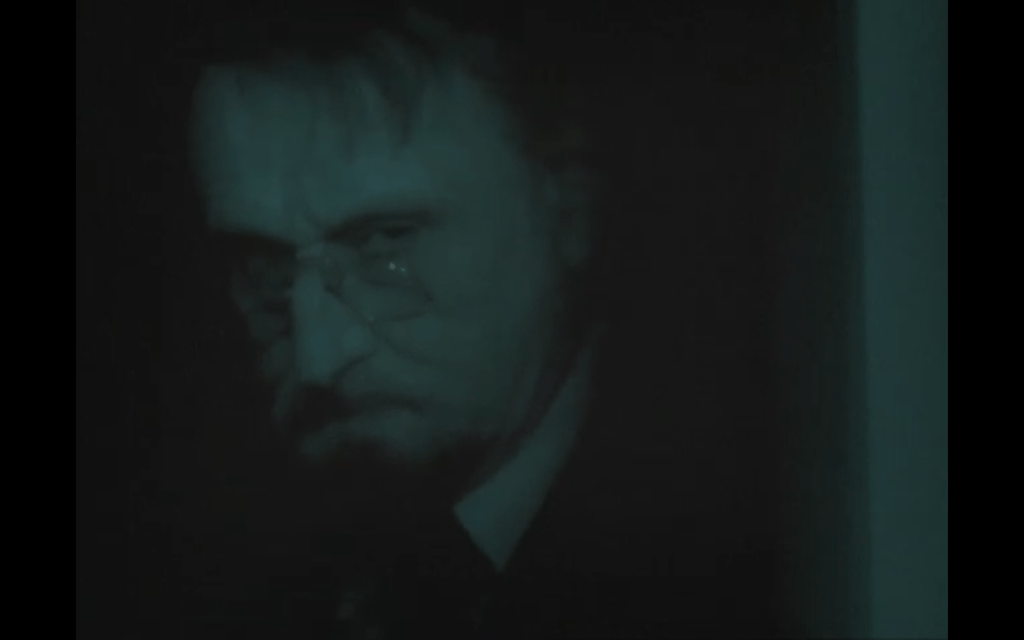
–
Stalin arriva e dona a Lénin un bastone, simbolo della benevolenza del Politburo nei confronti del leader malato. La conversazione tra i due verte su molte cose: sul veleno che Lénin vorrebbe (l’aveva già richiesto nel 1921) e che il Politburo continua a negargli, su Tróckij sempre contrario a dare a Lénin più libertà di movimento, sull’ancora endemico analfabetismo dei membri del Partito (i proclami e le notizie sono scritti con grossolani errori di ortografia), sul perché la nascente Unione Sovietica tenga l’originatore della Rivoluzione segregato in una dáča senza linea esterna del telefono, con nessuno che gli scrive, lasciato a morire lentamente senza neanche la possibilità di suicidarsi: per un animo violento, come Lénin appare dai pensieri che Sokúrov gli attribuisce, e che con Stalin teorizza su quanto solo la violenza e il terrore possano tenere insieme l’umanità, è una tortura non poter agire su se stesso violentemente e darsi la morte. Stalin però non sembra per nulla prendere sul serio il leader e lo abbandona quasi ridacchiando dopo pochi minuti di conversazione.
–
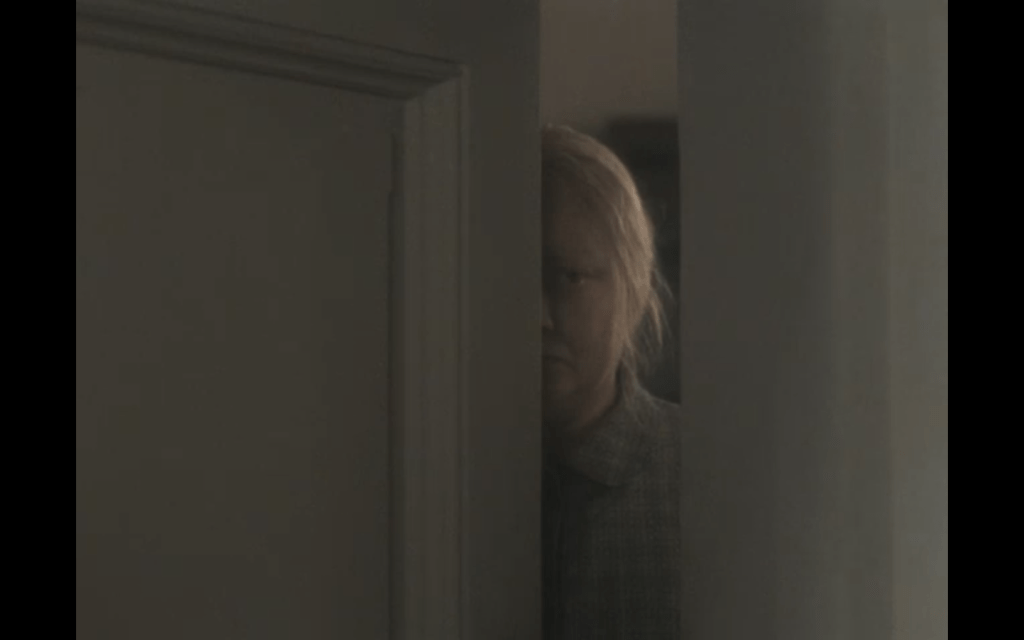
–
Subito dopo la partenza di Stalin, a Górki Léninskie è servito il pranzo, durante il quale Lénin non appare per nulla lucido: non si ricorda di aver appena parlato con Stalin, anzi, non sa chi sia l’uomo col quale si è intrattenuto: gli è parso un georgiano qualsiasi o addirittura un ebreo. Krúpskaja e Ul’jánova lo rimproverano di aver chiesto il veleno, timorose che dopo la sua morte il Partito potrebbe non essere così benevolo con loro, ma Lénin non le ascolta e si stupisce del lusso di Górki Léninskie, del parco pieno di palme importate, della tavola piena di argenteria e della squisita zuppa servita: come possono avere tante ricchezze se il popolo russo muore di fame? Krúpskaja e Ul’jánova lo rassicurano dicendo che niente appartiene a loro, ma è tutto frutto di esproprio, quindi di un furto. A quel punto, Lénin va su tutte le furie e con il braccio buono agita il bastone appena donatogli da Stalin come un’arma sfasciando le porcellane e colpendo le donne e i militari, che intervengono con la forza a immobilizzare il malato e a riportarlo a letto. Privo di sensi, Lénin sogna la madre, che quasi gli suggerisce di lasciarsi andare e di seguirla nella morte (una scena un po’ somigliante a quelle di Mat’ i syn, uno dei primi film di Sokúrov ad aver fatto breccia all’estero nel 1997), ma lui si rifiuta, dicendo che è troppo presto, che deve ancora fare molte cose, e chiede alla madre consigli su come moltiplicare 17 per 22.
Nel pomeriggio, un Lénin più calmo si lascia fare il bagno e condurre nel parco da Krúpskaja. Mentre sono fermi sotto un gazebo, apparentemente vicino alla grotta adiacente al Kruglyj prud (lo stagno rotondo) di Górki Léninskie, Krúpskaja è richiamata in dáča da una chiamata al telefono, evento sorprendente visto che per tutto il film si è detto che le linee esterne erano fuori uso: per rispondere, Krúpskaja lascia Lénin, che, sentendosi solo in mezzo al parco, disperatamente si mette a urlare senza che nessuno lo senta. Esausto dalle urla, Lénin sembra ritrovare la serenità osservando il cielo azzurro che spunta dalle nuvole che si diradano e chiudono, col sereno, il cerchio narrativo aperto all’incubo del temporale all’inizio.
–

–
Se alla fine di Molóch non si può fare a meno di rimanere inorriditi dal discorso di Sokúrov su un nazismo psicologico e interiore che attanaglia le nostre coscienze di occidentali, alla fine di Teléc è più difficile trarre conclusioni o insegnamenti.
La denuncia di un regime già appena nato ampiamente spionistico e malsano (mentre in Molóch si vedeva la piena maturità del regime hitleriano), anche virato in burletta o in commedia (già quasi come nel Maestro e Margherita di Bulgákov, ambientato però in pieno stalinismo: un lato parodico affidato soprattutto ai militari capeggiati da Pákaln, buoni a nulla caciaroni che non riescono neanche a sequestrare la macchina fotografica a un fotografo molesto giunto a immortalare la convalescenza del leader), per di più forgiato da un pensatore che sentiamo violentissimo e che vediamo completamente fuori di sé, si sente voler essere la finalità principale di Sokúrov. Ma le sue immagini mostrano qualcosa di più profondo oltre alla mera stigmatizzazione di un regime già marcio alla nascita.
In Èlégija žízni: Rostropóvič, Višnévskaja (Elegia della vita), il documentario che ha girato nel 2007 sui grandi musicisti russi, Sokúrov, nella voce fuori campo, afferma di essere partito con Rostropóvič ma poi, conoscendola, non ha potuto fare a meno che concludere il film con le riflessioni di Višnévskaja. In Teléc potrebbe essere avvenuta una cosa simile: la denuncia potrà essere anche stata l’idea di partenza, ma poi il sistema visivo della macchina da presa come visione impedita dello sguardo di Lénin, in eterno suggerimento di un aspetto del profilmico, cioè dell’esistente, che ci sfugge, ha trasceso quest’idea e ha aperto a una vera critica al Comunismo come teoria del tutto unitaria della scienza sociale.
Le immagini, più del soggetto, di Teléc avvertono della caducità del credo sovietico non tanto per le implicazioni violente o liberticide, ma proprio per le fallaci premesse teoriche secondo cui quel credo si professava l’ultimo e il definitivo sistema politico possibile, capace di risolvere tutto e per sempre. Quella sicurezza voluta e teorizzata è infranta dal cinema di Teléc, capace di mostrarci il più importante innescatore di quella credenza che si inganna con le sue immagini all’apparenza facili, asciutte e comprensibili ma invece caduche, instabili, inesatte e frustranti di percepire un di più di visione che non afferrano e che sfiorano senza poterlo mai raggiungere. Perché la realtà e l’esistenza scappano a qualsiasi doxa e a qualsiasi gabbia intellettuale, alla più benintenzionata come alla più violenta.
Le immagini di Teléc dimostrano l’inconsistenza di ogni logica di potere che si erge a risolvere come una panacea i mali del mondo lavorando sul farci intravedere significati e realtà che non carpiremo mai. Forse Teléc di Sokúrov, oltre alla dichiarata Krásnaja zvezdá (la Stella rossa) di Bogdánov (il bolscevico meno materialista che stava tanto antipatico al pratico Lénin), è stata un’ulteriore fonte di ispirazione per il romanzo Proletkult di Wu Ming (2018).
E in tempi di uomini e donne forti al potere, che tranquillizzano di «pensare a tutto loro», tanto da cavalcare scriteriatamente una crisi della democrazia rappresentativa, l’avvertimento di Sokúrov sull’impossibilità di trovare soluzioni una volta per tutte non può che essere d’aiuto nel navigare la complessità che ci circonda. Una complessità a cui dovremo rassegnarci, imparando che non potremmo mai semplificarla affatto, in un segno o nell’altro, ma possiamo solo contemplarla, limitando il più possibile i nostri inevitabili errori.
Lascia un commento